Viviamo in un’epoca di sfiducia diffusa. Sfiducia verso le istituzioni, verso i media, verso la scienza. Sfiducia verso chi parla in pubblico e verso le stesse parole con cui proviamo a capirci. Ma questa sfiducia non è solo un sintomo: è diventata la grammatica invisibile della nostra comunicazione.
Sfiduciati. Democrazia e disordine comunicativo nella società esposta (Feltrinelli 2025) è un libro che nasce da una domanda per me urgente: che cosa sta succedendo al nostro modo di comunicare quando la trasparenza si trasforma in sospetto, la pluralità in rumore e la partecipazione in caos?
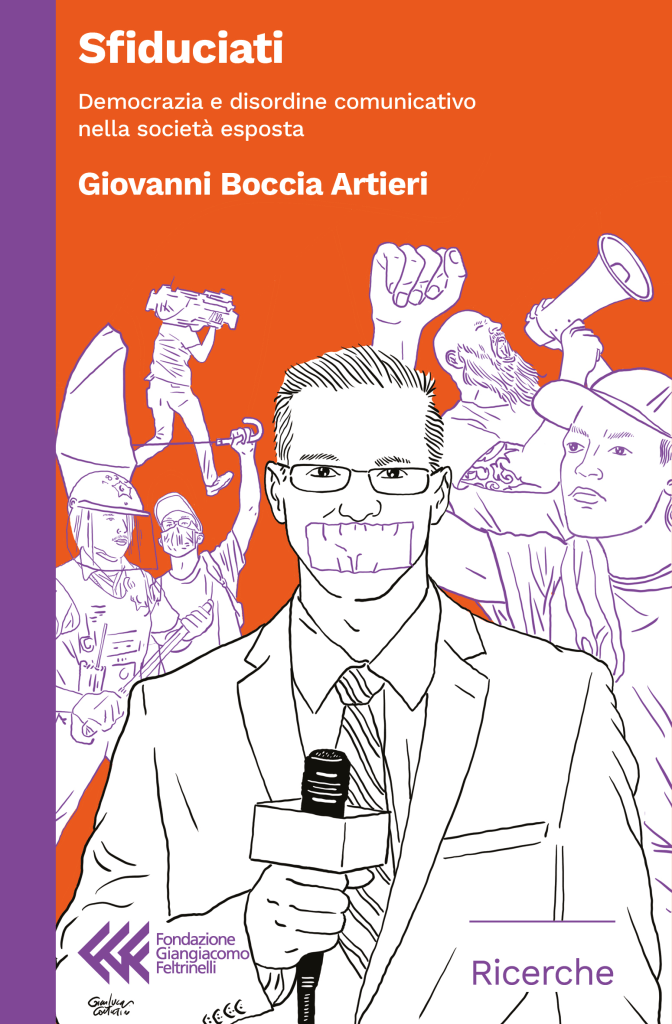
drawing courtesy of Gianluca Costantini
Un nuovo regime comunicativo
Il libro prende le mosse da una diagnosi radicale: non siamo più soltanto nell’epoca della post-verità, ma in quella più insidiosa della post-affidabilità.
Non è solo la verità ad essere contestata, ma le condizioni stesse che ci permettono di distinguerla dal falso: la credibilità delle fonti, la legittimità delle mediazioni, il riconoscimento delle competenze. La fiducia, che tiene insieme la comunicazione pubblica, si è disgregata. Oggi, ci fidiamo meno di chi ha autorevolezza e più di chi ci sembra “simile”, “vicino”, “autentico”.
È questo lo sfondo del primo grande mutamento: la crisi dell’affidabilità come infrastruttura discorsiva. Non sappiamo più a chi credere, né perché. Le emozioni sostituiscono la verifica, l’appartenenza rimpiazza l’argomentazione. Non importa tanto se un contenuto è vero, ma se “risuona con me”.
La seconda trasformazione riguarda la piattaformizzazione della sfera pubblica. Le piattaforme digitali non sono semplici canali informativi, sono ambienti algoritmici che organizzano ciò che diventa visibile, ciò che circola, ciò che merita attenzione. La visibilità non è più distribuita in base al valore informativo, ma in base alla capacità di generare engagement: le piattaforme non sono spazi neutri, ma ambienti opachi e polarizzanti, che plasmano la visibilità e riorganizzano la fiducia.
L’opinione pubblica si trasforma così in un mosaico frammentato di pubblici interconnessi, micro-sfere, bolle emozionali. In questo ecosistema, il discorso pubblico perde coesione, si disarticola e si alimenta di risonanze emotive, perde continuità e si nutre di antagonismo, spettacolarizzazione, polarizzazione.
Ed è proprio in questo scenario che emerge una terza e decisiva dinamica, quella che nel libro definisco come fringe democracy.
Una democrazia che prende forma ai margini e attraverso i margini, ma non nel senso di una marginalità separata. Al contrario: il fringe non è un “fuori”, è una zona porosa e ambivalente in cui si sviluppano linguaggi, narrazioni e comunità che sfidano il centro, lo contaminano e ne riconfigurano le grammatiche.
La fringe democracy è l’indicatore di una democrazia esposta, instabile, attraversata da soggettività post-mediali che usano le piattaforme per costruire contro-narrazioni, identità alternative e dispositivi oppositivi. Ma in questa reinvenzione dal basso si nasconde anche un rischio sistemico: quello che la sfiducia, il sospetto e la polarizzazione diventino non eccezioni, ma regole della comunicazione politica.
Nelle zone fringe, la marginalità non è un difetto: è una leva retorica e affettiva. È proprio perché si sentono “fuori dal sistema” che certi attori guadagnano credibilità. E sono spesso proprio le logiche del centro – censura, deplatforming, esclusione – a rafforzare queste narrazioni, generando un paradosso autoimmune: la democrazia, cercando di proteggersi, alimenta i suoi stessi virus.
La fringe democracy non è solo un’anomalia da correggere: è una delle forme più visibili della democrazia nel tempo della piattaformizzazione. Una democrazia che, nel suo aprirsi, si espone. E in questa esposizione, sperimenta insieme nuove possibilità e nuove vulnerabilità.
Autoimmunità comunicativa: quando la democrazia si attacca da sola
La tesi centrale del libro si sviluppa a partire da un concetto chiave elaborato da Jacques Derrida e qui trasposto nell’ambito della comunicazione pubblica: l’autoimmunità.
In ambito medico, l’autoimmunità si verifica quando un organismo finisce per attaccare i propri stessi anticorpi, cioè i dispositivi di difesa che dovrebbero proteggerlo. In ambito politico, si manifesta quando un sistema democratico, nel tentativo di difendere i propri principi fondamentali – apertura, pluralismo, libertà di espressione – finisce paradossalmente per eroderli.
Viviamo oggi in quella che potremmo chiamare una democrazia autoimmunitaria: un assetto in cui le stesse condizioni che dovrebbero rafforzare la coesione sociale diventano fattori di vulnerabilità sistemica.
La libertà di parola, la disintermediazione informativa, la molteplicità delle fonti – elementi essenziali di una cultura democratica – si trasformano in canali attraverso cui si diffondono sfiducia sistemica, polarizzazione affettiva e logiche oppositive generalizzate. La democrazia, insomma, si espone senza protezione a ciò che la indebolisce.
L’autoimmunità comunicativa è il nome di questo paradosso: una società che, nel moltiplicare le possibilità di parola, disconnette il legame tra parola e responsabilità, e nel tentativo di includere tutte le voci, apre varchi attraverso cui si diffondono forme di delegittimazione sistematica.
Non è la censura a minacciare la sfera pubblica, ma la sua sovraesposizione al rumore, al sospetto e alla dissoluzione dei criteri di affidabilità condivisi.
Ma in questa stessa esposizione risiede anche una possibilità. Come accade nei sistemi biologici, anche nel sistema democratico l’autoimmunità non è solo una minaccia, ma può diventare una condizione generativa: uno stimolo alla rigenerazione delle proprie difese culturali e discorsive.
La fragilità democratica non è solo un rischio: è anche un compito.
Significa imparare a convivere con la complessità senza ricadere nel cinismo, e costruire collettivamente quei dispositivi – cognitivi, simbolici, relazionali – che ci consentano di abitare l’esposizione senza esserne travolti.
Non basta correggere. Bisogna curare
Per affrontare questa condizione non bastano fact-checking o agire con la regulation. Serve un’altra idea di democrazia: una democrazia della cura, capace di prendersi carico delle proprie fragilità.
Serve un’immunità democratica che non sia chiusura, ma capacità collettiva di discernere, orientarsi, sostenere il legame sociale.
La seconda parte del libro prova allora a rispondere a questa sfida con un approccio che delinea quattro percorsi di cura:
- anticorpi cognitivi, per vivere nel flusso informativo senza esserne travolti.
- ecologie del discorso, per ritrovare parole che riconnettono invece di ferire.
- valorizzazione dell’informazione, come bene comune e non come prodotto di consumo.
- cura democratica nell’età algoritmica, per ripensare la relazione tra tecnologia, visibilità e cittadinanza.
Ogni capitolo è un esercizio di manutenzione: del linguaggio, dell’attenzione, della fiducia.
Ogni proposta è pensata come una soglia per rendere abitabile l’apertura a cui la società ci espon.
Una sfida culturale e politica
Il libro è un saggio scientifico, costruito su fonti, studi empirici e una cornice teorica. Ma è anche, in fondo, una proposta politica in senso ampio.
Non una proposta di partito, né un programma di policy, ma una riflessione sulla democrazia come spazio fragile, da ripensare e di cui prendersi cura.
Non si tratta di restaurare un passato mitico – quello di un’informazione pura, di una verità condivisa, di un pubblico razionale che forse non è mai esistito – ma di riconoscere le condizioni mutate del presente e provare a rigenerare, dentro di esse, le possibilità del legame democratico.
Nel tempo dell’esposizione permanente – dove tutto può essere detto, giudicato, frainteso, amplificato – la democrazia non può più fare affidamento solo sulle sue forme istituzionali. Deve diventare anche una pratica culturale quotidiana, una tecnologia relazionale, un esercizio critico.
Significa ripensare il modo in cui parliamo, ci informiamo, ci indigniamo, ci fidiamo.
Il libro si muove così lungo un crinale: tra analisi e impegno, tra diagnosi e progettazione.
Perché la democrazia non è solo un sistema politico ma è una forma di vita comunicativa.
E come ogni forma di vita, va coltivata, riparata, difesa non solo dagli attacchi esterni, ma anche dalle sue derive interne, dalle sue autoimmunità.
“La democrazia non sarà mai immune. Ma può imparare a convivere con i suoi virus, a contenerli, a trasformarli. È questa, forse, la democrazia a venire: esposta, vulnerabile, e proprio per questo ancora possibile.”
