Il 26 giugno a Milano ho organizzato per la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli un Camp su “Fake politics. Sfide alla sfera pubblica dalla disinformazione alla fringe democracy”.
Premessa
Le radici più profonde muovono da un Progetto PRIN PNRR 2022 di cui sono PI e che coinvolge Sara Bentivegna come unità di Roma Sapienza e Rossella Rega per l’Unità di Siena e che ha come titolo Countering Online Radicalization and incivility in ITaly: from fringe to mainstream – CORIT e che vede in momenti come questi il modo di portare i temi di ricerca nel dibattito pubblico e tra le istituzioni sociali (quella cosa che in Università chiamiamo attività di Terza Missione). E va ringraziato da subito il team dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo che segue con me questa parte di progetto e cioè Stefano Brilli, Elisabetta Zurovac, Valeria Donato, Camilla Folena, Francesco Maria Parente.

Fake politics. Sfide alla sfera pubblica dalla disinformazione alla fringe democracy
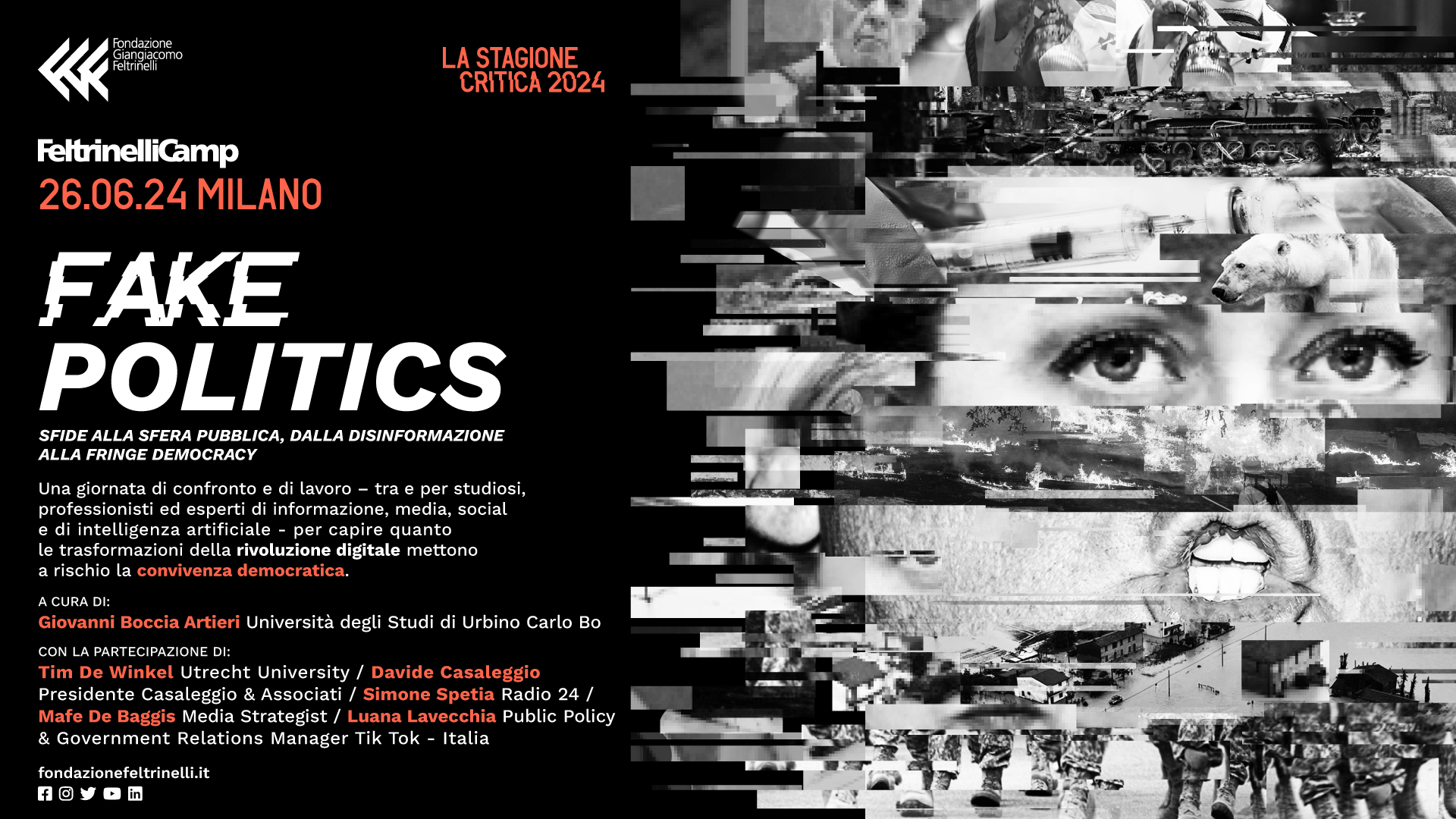
L’idea dietro al Feltrinelli Camp è di esaminare le sfide poste dalla piattaformizzazione della politica e della sfera pubblica, e il modo in cui questa influisce sulla trasformazione della comunicazione politica e della democrazia. Verranno discusse quindi le cause e gli effetti dell’inciviltà discorsiva, della polarizzazione affettiva e delle diverse forme di disordine informativo, ma anche l’emergere di nuove voci dissonanti e marginali che hanno raggiunto il centro della scena.

Per molti anni, voci dissenzienti che si definiscono “alternative” o “anti-mainstream”, hanno sfruttato il potere di distribuzione delle piattaforme dei social media come “canali neutrali”, permettendo alle loro posizioni marginali di entrare nel mainstream e di influenzare il discorso pubblico e la politica istituzionale. Queste voci, sempre più presenti nel dibattito pubblico, stanno modificando la natura stessa delle discussioni e (forse) della democrazia. Non solo problemi di disinformazione, dunque, ma la necessità di confrontarsi con realtà che muovono da spazi mediali fringe.
Parlare di “fringe democracy” è un invito a guardare a quei sistemi di pensiero, pratiche e movimenti politici che esistono alla periferia delle norme e dei valori democratici tradizionali, che diventano oggi più visibili nella sfera pubblica. Sebbene questi sfidino principi democratici consolidati, come il pluralismo, l’inclusività, il rispetto dei diritti delle minoranze e l’adesione allo Stato di diritto, il loro coinvolgimento sembra diventare sempre più strategico anche nelle dinamiche di costruzione del consenso da parte degli attori politici tradizionali.

Il panorama contemporaneo delle piattaforme digitali è infatti caratterizzato da un intricato mix di spazi pubblici, semi-pubblici e privati. Questi spazi variano in termini di visibilità, regolamentazione e frequentazione, ma sono allo stesso tempo interconnessi attraverso dinamiche di migrazione reciproca tra ambienti marginali e mainstream. La comprensione di queste dinamiche è fondamentale per comprendere l’attuale deterioramento del dibattito pubblico e il modo in cui vi aumenta la concentrazione di elementi di tossicità.
Tali processi sono rafforzati dalla partecipazione dei cittadini a piattaforme online alternative o “fringe”. Diverse ricerche hanno collegato questi spazi – tecnici e sociali – a ecosistemi di disinformazione, alla diffusione di narrazioni e ideologie cospirazioniste e alla normalizzazione del pensiero populista ed estremista. Numerosi episodi recenti, nonché una crescente letteratura accademica, hanno mostrato come esista una relazione interdipendente tra l’aumento degli spazi online alternativi e la crescita delle forme dell’estrema destra. Questi spazi online “appartati” possono funzionare come laboratori per lo sviluppo di punti di vista estremisti che penetrano progressivamente nel mainstream. Allo stesso tempo, questi spazi danno voce a comunità emarginate e svantaggiate, quindi possono anche rappresentare nuove risorse per il dibattito pubblico.

La relazione tra piattaformizzazione della sfera pubblica e democrazia fringe si spinge lungo diversi percorsi che diviene necessario esplorare:
- il modo in cui voci marginali – perché sottorappresentate o perché incompatibili con le norme dell’ordine democratico – vengono amplificate;
- le dinamiche che portano ideologie radicali a venir diffuse e normalizzate più di quanto lo siano nella società in generale;
- i processi di radicalizzazione basati su logiche di polarizzazione affettiva identitaria, che si costruiscono dalla combinazione di elementi “controcorrente” provenienti dai media di massa, dalle subculture digitali e da conversazioni quotidiane che intensificano l’odio tra fazioni;
- lo sviluppo di network transnazionali che mirano a produrre e distribuire i loro contenuti su questi spazi “fuori dai radar”.
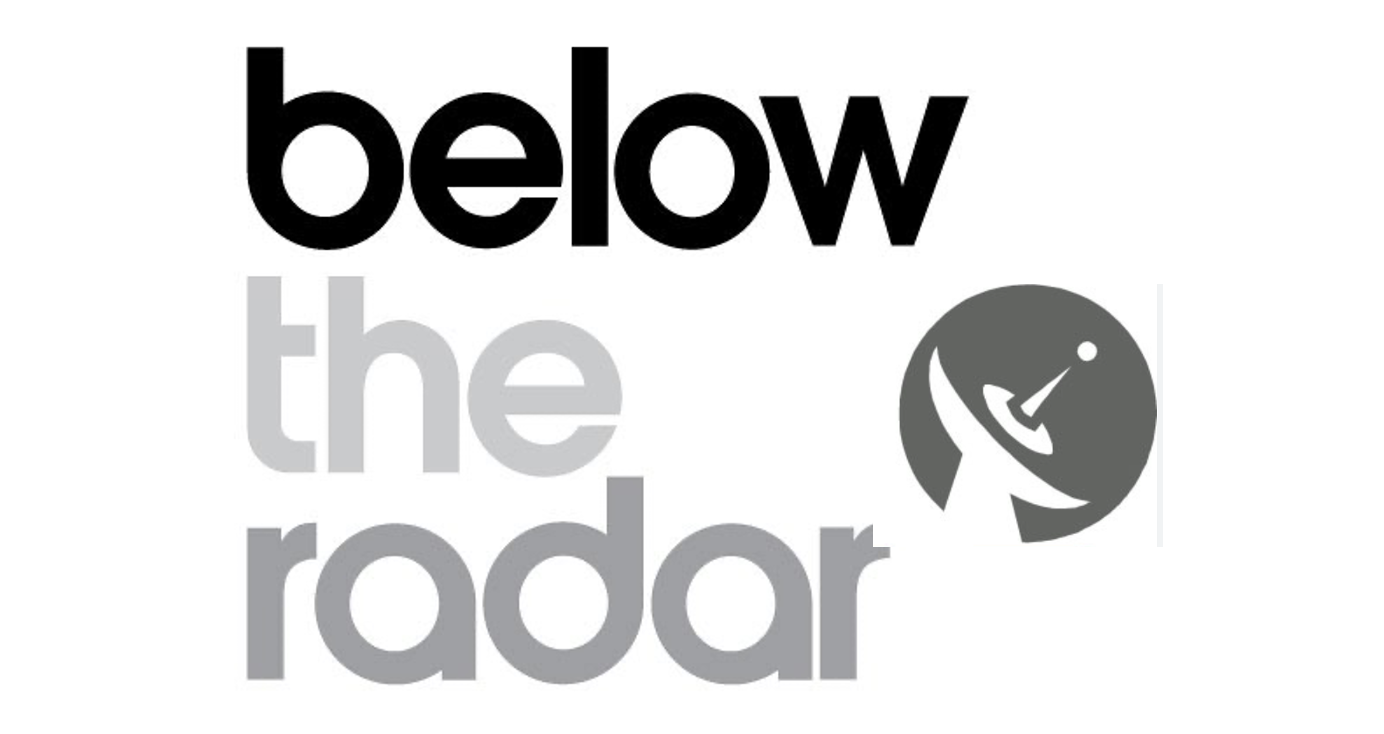
Feltrinelli Camp
Sarà una giornata complessa che metterà in relazione ricercatrici e ricercatori, policy makers, spin doctors, analisti di media e politica, giornaliste e giornalisti attorno a tavoli di lavori che ho affidato a diversi esperti: Polarizzazione e democrazia (Augusto Valeriani e Laura Iannelli), Inciviltà e discorsi d’odio (Sara Bentivegna e Rossella Rega), Piattaforme digitali e democrazia (Michele Sorice e Maria Francesca Murru), Dati e influenza sulla comunicazione (Fabio Giglietto), Dalla democrazia dei cittadini alla democrazia dei fan (Donatella Campus e Marco Mazzoni), Influencer e attivismo (Simone Tosoni), Comunicazione e politica oltre la rappresentanza (Luigi Ceccarini e Emiliana De Blasio). Ogni tavolo avrà una decina di persone a discutere… troppe per citarle tuttə ma saranno presenti nel resoconto dei lavori.
Avremo due keynote che ritengo rilevanti per il discorso da costruire e discutere collettivamente:
Tim De Winkel (Utrecht University) “Fringe platforms: radical platform technology as alternative models of public deliberation and the platformization of the public sphere”
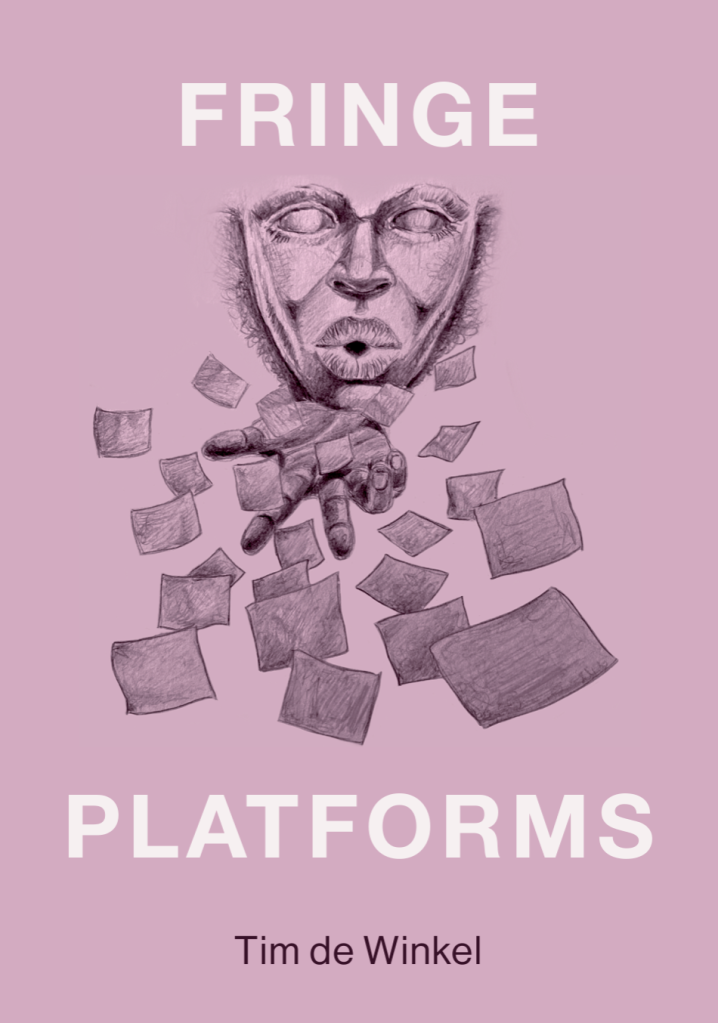
Davide Casaleggio (Presidente Casaleggio & Associati, Fondatore dell’Associazione Rousseau e del progetto Camelot) “AI, digitale e democrazia: una convivenza non scontata”
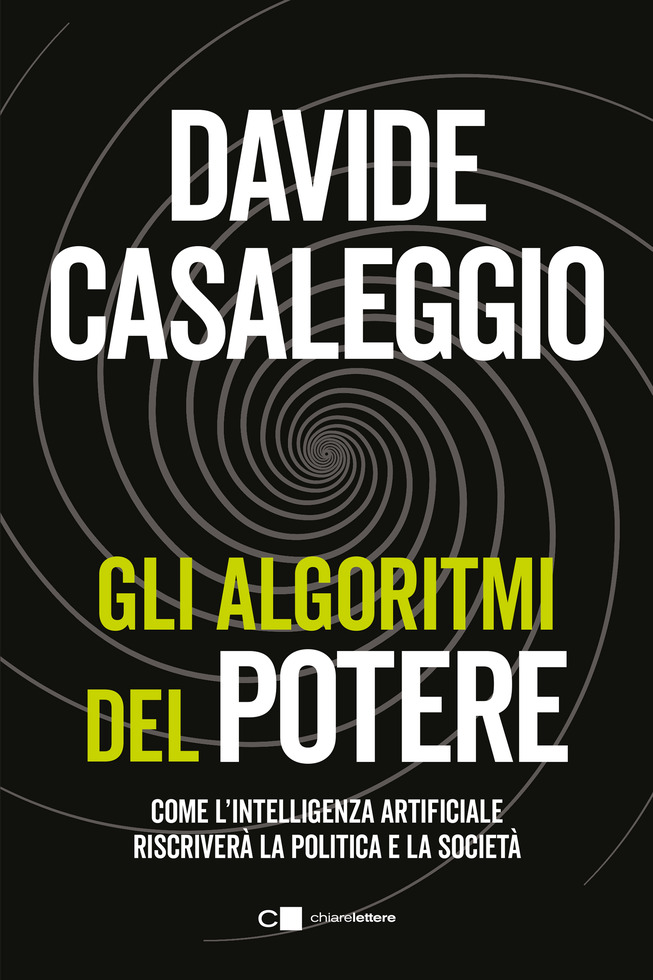
Chiuderà la giornata un panel che coinvolgerà più voci attorno al tema (non)Mainstream Comunicazione e Politica: Simone Spetia (giornalista Radio 24); Mafe De Baggis (Media Strategist); Luana Lavecchia (Public Policy & Government Relations Manager Tik Tok – Italia).
